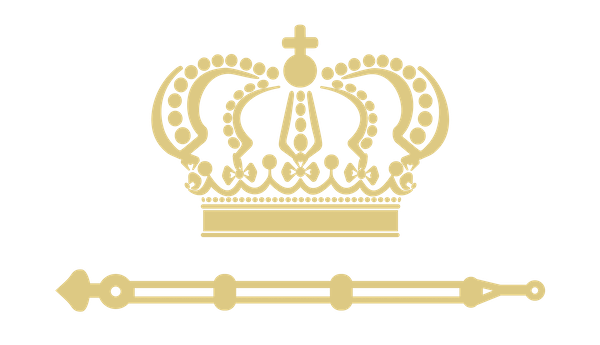Letteratura sulla nobiltà
La rubrica raccoglie definizioni, descrizioni, aforismi, sulla nobiltà apparsi nella letteratura europea. L’intento non è quello di cercare postume esaltazioni o giustificazioni, ma di raccogliere testimonianze di prospettive e di concezioni allo scopo di porre dei tasselli nel dibattito sull’evoluzione dell’idea di nobiltà nel corso dei secoli.
(Si ringrazia Tomaso Ricardi di Netro per l’importante contributo)
1. Elogio del nobile piemontese
Nel 1880 fu pubblicato un libro antologico su Torino nei suoi vari aspetti: artistico, storico, politico, industriale, militare…, affidandone la redazione ai maggiori esperti ed alle migliori penne dei singoli settori, come tra gli altri, Vittorio Bersezio, Edmondo de Amicis, Giuseppe Giacosa. In questo osanna dei bogia-nen e della loro “Grissinopoli”, ho trovato queste righe di alto valore letterario e di profonda ed autentica verità (TRN)
Il nobile piemontese è una delle più belle figure da romanzo e da storia. Alfieri lo ha descritto dal suo lato comico, nelle sue frivolezze: Massimo d’Azeglio l’ha schizzato da par suo dal lato migliore, quello della devozione al Re ed alla Patria, del valore personale, dell’animo elevato. Egli stesso ne fu la personalizzazione più simpatica, e la sua vita delinea il trasformarsi di questo tipo alquanto medievale nel gentiluomo, patriota e cittadino italiano.
Il cavaliere piemontese, generalmente non ricco per le vicende politiche del principio di questo secolo [il XIX, n.d.c.] si aggruppava intorno al trono, divideva coi suoi principi l’esilio e anche la borsa, riconosceva da essi la vita come un vassallo del medio evo, e per essi la esponeva sul campo senza ostentazione e con la coscienza del dovere.
Fiero del suo blasone, elegantemente prepotente, serviva nell’esercito con passione e disinteresse. Spesso portava a morire in battaglia il cavallo prima di pagarlo; tenuto a corto di quattrini dalla famiglia, era tuttavia sempre un signore nel modo di spendere. Avvezzo ad un continuo avvicendarsi di fortuna, era oggi circondato da ebrei e da strozzini, carico di cambiali in scadenza, domani risollevato nel credito da un’eredità inaspettata, da un matrimonio ben combinato; mancando tali risorse, un vecchio zio milionario o il Re stesso intervenivano a pagarne i debiti.
Malgrado ciò, allegro sempre, mai sprovvisto di sangue freddo; sdegnoso coi borghesi, è generoso coi soldati e cede a favor loro il soprassoldo delle sue medaglie al valor militare. Mette a rumore una città per uno scandalo amoroso, fa parlar tutta Torino di una sua avventura ardita, di una sua pazza scommessa; getta lo scompiglio in un convento scandalizzando le monache pudiche, fracassa le maioliche distese per terra montandovi sopra col cavallo, dà il frustino in faccia a qualsiasi pitocco osi contraddirlo, e infine dice il rosario ogni sera con i vecchi e le donne della famiglia nel palazzo avito, lascia morendo un grosso legato testamentario al suo reggimento, non si oppone a che la madre pia riconosca dal cielo la sua fortuna nelle battaglie ed appenda un quadro votivo alla Madonna della Consolata quando ei ritorna illeso dalla guerra.
Tale era il nobile piemontese, tipo di paladino medioevale, ingentilitosi senza perdere di vigoria, civilizzato senza diventar prosaico. Forse l’ultima delle figure leggendarie che abbia sopravvissuto alla rivoluzione francese.
da: Vittorio Turletti, Torino militare, in Torino, Torino, Roux e Favale, 1880, pp.779-781.
2. De Maistre e la nobiltà
da: Joseph de Maistre, Du Pape, ses maitres,
consultata l’edizione di Paris, Charpentier, 1851, n. a pag. 310
La noblesse n’étant qu’un prolongement de la souveraineté, magnum Jovis ingrementum, elle répète en diminutif tous les caractères de sa mère, et n’est surtout ni plus ni moins humaine qu’elle; car c’est une erreur de croire que, à proprement parler, les souverains puissent anoblir; ils peuvent seulement sanctionner des annoblissements naturels. La veritable noblesse est la gardienne naturel de la Réligion; elle est parente du sacerdoce, et ne cesse de la protéger. Appius Claudius s’écriait dans le sénat romain:”La Réligion appartient aux patriciens, auspicia sunt patrum“. Et Bourdaloue, quatorze siècles plus tard, disait dans une chaire chrétienne: “La sainteté, pour être éminente, ne trouve point de fond qui lui soit plus propre que la grandeur” (Serm. sur la Concep., p.11). C’est la même idée revêtue de part et de l’autre des couleurs du siècle. Malheur aux peuples chez qui les nobles abandonnes les dogmes nationaux! La France, qui donna tous les grandes exemples en bien et en mal, viens de le prouver au monde; car cette bacchante qu’on appelle révolution francaise, et qui n’a fait que changer d’habit, est une fille née du commerce impie de la noblesse francaise avec le philosophisme dans le dix-huitième siècle. Les disciples de l ‘Alcoran (il Corano, n.d.c.) disent “qu’un des signes de la fin du monde sera l’avancement des personnes de basse condition aux dignités éminentes” (Pocotke cité par Sale, Obs. hist. et crit. sur le mahom., sect. IV) C’est une exagération orientale qu’une femme de beaucoup d’esprit réduite à la mesure européenne (Lady Mary Wortley Montague’s Works, tom. IV, p.223,224). Ce qui parait sur, c’est que, pour la noblesse comme pour la souveraineté, il y a une relation cachée entre la Religion et la durée des familles. L’auteur anonyme d’un roman anglais intitulé le Forester, dont je n’ai pu lire que des extraits, a fait, sur la décadence des familles et les variations de propriétés en Angleterre, des singulières observations, que je rappelle sans avoir le droit de les juger. “Il faut bien, dit-il, qu’il y ait quelque chose de radicalement et d’alarmiquement mauvais dans un système qui, en un siècle, a plus détruit la successione héréditaire et les noms connus, que toutes les dévastations produites par les guerres civiles d’York et de Lancaster et du règne de Charles Ier ne l’avaient fait peut-ètre dans les trois siècles précedents pris ensemble, etc (Anti-Jacobin Rev. and Magazine, nov. 1803, n.LVIII, p.249).
Si les anciennes races anglaises avaient réellement péri depuis un siècle environ, en nombre alarmiquement considérable (ce que j’ose point affirmer sur un témoignage unique), ce ne serait que l’effet accéléré, et par conséquent plus visible, d’un jugement dont l’exécution aurait, néanmoins, commencé d’abord après la faute. Pourquoi la noblesse ne serait-elle pas moins conservée, après avoir renoncé à la Religion conservatrice? Pourquoi serait-elle traitée mieux que ses maitres, dont les règnes ont été abrégés?
J. de Maistre, Considérations sur la France
[…]
Il y a dans chaque État un certain nombre de familles, qu’on pourrait appeler co-souveraines, même dans les monarchies; car la noblesse, dans ces gouvernements, n’est qu’un prolongement de la souveraineté. Ces familles sont les dépositaires du feu sacré; il s’éteint lorsqu’elles cessent d’être vierges.
C’est une question de savoir si ces familles, une fois éteintes, peuvent être parfaitement remplacées. Il ne faut pas croire au moins, si l’on veut s’exprimer exactement, que les souverains puissent anoblir. Il y a des familles nouvelles qui s’élancent, pour ainsi dire, dans l’administration de l’État; qui se tirent de l’égalité d’une manière frappante, et s’élèvent entre les autres comme des baliveaux vigoureux au milieu d’un taillis. Les souverains peuvent sanctionner ces anoblissements naturels, c’est à quoi se borne leur puissance. S’ils contrarient un trop grand nombre de ces anoblissements, ou s’ils se permettent d’en faire trop “de leur pleine puissance,” ils travaillent à la destruction de leurs États. La fausse noblesse était une des grandes plaies de la France: d’autres empires moins éclatants en sont fatigués et déshonorés, en attendant d’autres malheurs.
La philosophie moderne, qui aime tant parler de hasard, parle surtout du hasard de la naissance; c’est un de ses textes favoris; mais il n’y a pas plus de hasard sur ce point que sur d’autres: il y a des familles nobles comme il y a des familles souveraines. L’homme peut-il faire un souverain? Tout au plus il peut servir d’instrument pour déposséder un souverain, et livrer ses États à un autre souverain déjà prince (1). Du reste, il n’a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner l’origine plébéienne: si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde (2).
(1) Et même la manière dont le pouvoir humain est employé dans ces circonstances, est toute propre à l’humilier. C’est ici surtout que l’on peut adresser à l’homme ces paroles de Rousseau: “Montre-moi ta puissance, je te montrerai ta faiblesse.”
(2) On entend dire assez souvent que si Richard Cromwel avait eu le génie de son père, il eût rendu le protectorat héréditaire dans sa famille. C’est fort bien dit!
Proportion gardée, il en est de la noblesse comme de la souveraineté. Sans entrer dans de plus grands détails, contentons-nous d’observer que si la noblesse abjure les dogmes nationaux, l’État est perdu (1).
(1) Un savant italien a fait une singulière remarque. Après avoir observé que la noblesse est gardienne naturelle et comme dépositaire de la religion nationale, et que ce caractère est plus frappant à mesure qu’on s’élève vers l’origine des notions et des choses, il ajoute: “Talche dee essur un grand segno que vada a finire une nazione ove i nobili disprezzano la religione natia” (Vico, Principi di Scienza nuova, Lib. II.) Lorsque le sacerdoce est membre politique de l’État, et que ses hautes dignités sont occupées, en général, par la haute noblesse, il en résulte la plus forte et la plus durable de toutes les constitutions possibles. Ainsi, le philosophisme, qui est le dissolvant universel, vient de faire son chef-d’oeuvre sur la monarchie française.
Encodées à partir de l’édition de 1844 (Société Nationale pour la propagation des bons livres, Bruxelles) par Denis Constales (dcons@world.std.com).Version du 18 février 1997. Copyright (C) 1997 Association de Bibliophiles Universels http://www.abu.org/
3. Contro la pretesa dell’aristocrazia inglese di essere il garante delle tradizioni e dello spirito genuino dell’Inghilterra
D. Cannadine, Declino e caduta dell’aristocrazia britannica
Milano, Mondadori, 1991, pp.716-721.
Abstract
Al termine di una rigorosa ricostruzione delle vicende della ricca e potente aristocrazia inglese a partire dalla seconda metà del secolo scorso, l’autore sferra un forte attacco all’attuale generazione ed alle sue strategie di mantenimento. La situazione italiana è ovviamente ben diversa, a cominciare dal diverso trattamento statale delle dimore private, ma tali pagine risultano di grande interesse ed attualità in quanto stigmatizzano il tentativo della aristocrazia britannica (titolata e non) di assumere il ruolo di garante e continuatore delle tradizioni e della schietta anima inglese. Ruolo su cui fondare il proprio impegno sociale e la propria sopravvivenza politica. (TRN)
Nel 1890 Gladstone aveva predetto che dopo cent’anni l’Inghilterra sarebbe ancora stata un paese dominato dalle grandi proprietà terriere e, probabilmente, anche dai membri dell’alta aristocrazia e della gentry che vi risiedevano. Nel centenario di questa profezia, sembra chiaro che Gladstone non avesse del tutto torto. In vista del 2000, l’uomo più ricco della Gran Bretagna continua ad esse un duca, come pure il più grande proprietario terriero privato del paese. La seconda Cameras legislativa consiste ancora di una maggioranza che ha il potere di legiferare semplicemente per diritto ereditario. Alcuni membri dell’aristocrazia tradizionale hanno conservato le loro abitazioni, le loro vaste tenute e il loro senso d’identità in una misura che sembrava impossibile nei giorni cupi e austeri della seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra. “Vivere sull’orlo dell’estinzione è divenuto per i proprietari terrieri uno stile di vita che è continuato fin dall’inizio di questo secolo. Può darsi che le voci sulla sua morte siano nondimeno esagerate”.
Ma come tutti i resti di un’epoca passata che si trascinano in un mondo nuovo e per molti aspetti alieno, questo quadro della sopravvivenza e continuità dell’aristocrazia deve essere collocato in una prospettiva più vasta. Infatti la posizione occupata dai nobili rimanenti nella Gran Bretagna degli anni Novanta è di gran lunga meno rilevante di quella dei loro antenati di cent’anni fa. Da un punto di vista economico, non possiedono più la maggior parte della terra, non costituiscono più essi stessi l’élite affluente e anche i più abbienti sono una minoranza tra i superricchi contemporanei. Da un punto di vista politico, i membri superstiti dell’alta aristocrazia e della gentry non formano la classe di governo e la maggior parte dei proprietari terrieri non hanno nessun ruolo nella politica locale o nazionale. Da un punto di vista sociale, il sistema delle onorificenze non è più basato sull’ereditarietà o sulla territorialità, le grandi cariche onorifiche sono di solito ricoperte da persone provenienti da altri ambienti sociali e né la vita di società londinese, né quella delle contee continuano nel vecchio significato del termine. Per quante prove sia possibile raccogliere a convalida della profezia di Gladstone, il fatto rimane che la classe terriera tradizionale ha cessato di esistere a livello di élite incontestata e suprema, nella quale la ricchezza, il rango e il potere sono altamente correlati e consolidati dalla preminenza territoriale.
Naturalmente vi sono alcuni singoli nobili estremamente ricchi, o politicamente attivi e che a volte compaiono nelle rubriche mondane. Ma questo è il risultato di circostanze particolari e di inclinazioni personali, più che della posizione di membri della vecchia aristocrazia. […]. La conseguenza è che i membri rimanenti della nobiltà e della gentry “sembrano meno coscienti della propria identità di classe” di quanto non lo fossero i loro antenati. Il loro senso collettivo di sé, i loro comuni sentimenti di solidarietà di gruppo e di superiorità collegiale sono in gran parte svaniti. Sanno di non essere più gli eletti del Signore.
Anche nelle sfere più alte della nobiltà, l’atteggiamento preferito è quello di una marginalità a basso profilo. Come ha affermato Anthony Sampton, “con la loro endogamia, le loro tenute isolate e la loro dedizione al passato, i duchi si stanno sempre più tagliando fuori dal mondo che li circonda”. […].
Questo drammatico indebolimento della posizione della classe terriera è meglio illustrato dalle nuove funzioni e condizioni delle superstite residenze di campagna di proprietà privata e patrizia. Nel loro pieno rigoglio e in forma pienamente funzionante, queste magioni esistevano in tutte le isole britanniche come baluardi di potere, espressioni di ricchezza e asserzioni di alta condizione sociale. Ciascuna era una cittadella da cui la famiglia terriera sovrintendeva ai propri affari economici, organizzava le sue attività politiche e proclamava la sua posizione sociale. In quanto tale, la residenza di campagna era un sistema da cui si irradiava verso l’esterno fiducia, leadership e autorità. Ma oggi l’equilibrio del potere e dell’iniziativa è fondamentalmente mutato. Coloro che si tengono strette le loro case avite lo fanno per un senso passatista e difensivo di devozione familiare più che dei sentimenti di fiducia nel loro ordine, nel loro scopo, nel loro futuro. Una volta queste magioni erano per i nobili il punto di partenza di tentativi sicuri e soddisfacenti; ora il loro mantenimento e la loro conservazione sono divenuti di per sé un’attività a tempo pieno. Le orgogliose cittadelle della vecchia élite sono divenute le vestali assediate dei loro controversi successori. […]
É questo desiderio diffuso di conservare la dimora della famiglia, anche quando quasi tutto il resto è sparito, che spiega la metamorfosi più recente dell’identità collettiva della classe terriera in quella di tutori del patrimonio “nazionale”. Il ragionamento fila pressappoco così: oggi i nobili rimasti non sono tanto i proprietari di beni privati, quanto i tutori della cultura nell’interesse di tutti. Una generazione dopo l’altra, si dice, i loro antenati hanno acquistato grandi opere d’arte e hanno arricchito e curato le loro collezioni. Alcuni proprietari erano già disposti un tempo a lasciare che i visitatori le ammirassero e la maggioranza senza dubbio intendeva che in un futuro esse fossero rese accessibili per l’edificazione delle masse. Nell’aprire le loro case al pubblico, i proprietari superstiti di oggi stanno semplicemente emulando la consuetudine ed esaudendo le aspirazioni dei propri antenati. Come ha affermato Lord Montagu nel 1974, “apparteniamo ai nostri beni più di quanto i nostri beni ci appartengano. Per noi non sono ricchezza, ma cimeli su cui abbiamo un sacro dovere di custodia”. La morale è evidente. Se i tutori del patrimonio nazionale si comportano di conseguenza con responsabilità ed altruismo, il governo a sua volta ha il dovere di assicurare che queste grandi magioni e collezioni d’arte rimangano intatte e che dia permesso ai loro proprietari di continuare in quel ruolo di residenti e tutori che esaudisce i loro desideri più profondamente sentiti e realizza le ambizioni più ardenti ed altruistiche dei loro antenati.
Il difetto di questo argomento consiste nel fatto che è storicamente molto poco convincente. In primo luogo, è fuorviante nella sua raffigurazione fervida ed adulatoria di una classe aristocratica, passata e presente, composta di mecenati delle arti dotati di senso civico, Naturalmente una piccola minoranza di proprietari di residenze di campagna è sempre stata composta (e lo è tuttora) da persone di vera raffinatezza, sensibilità e discernimento le quali hanno tratto un vero diletto (e tuttora lo traggono) dal collezionare ed esporre cose magnifiche. Ma questo non è mai stato vero per la maggioranza. Perfino nel loro pieno rigoglio, la maggior parte dei grandi nobili e della gentry erano di fatto persone incolte e grossolane, che dedicavano poco tempo alle opere d’arte, non le collezionavano sistematicamente, non avevano grande cura dei loro beni e non nutrivano nessun interesse nell’esporli a pubblico beneficio, né allora né per il futuro. […] Soltanto dal 1945 la maggioranza dei proprietari di residenze di campagna ha acquisito una maggiore coscienza culturale, che è la condizione indispensabile necessaria per il nuovo ruolo di autodesignati tutori del patrimonio “nazionale”.
Inoltre, questo argomento è fuorviante perché cerca di stabilire una continuità illusoria tra concezione passata della residenza di campagna e l’odierno business delle case signorili. Indubbiamente, vi sono sempre stati in passato dei grandi nobili disposti ad aprire le porte delle proprie abitazioni a visitatori occasionali. Ma il turismo di massa di oggigiorno, nel modo che si è sviluppata fin dal 1945, è qualcosa di fondamentalmente diverso. Infatti questo proprietari non sono interessati ad esporre le loro collezioni d’arte gratis per un senso di noblesse oblige a pochi visitatori dotati di discernimento: al contrario, cercano di sfruttare i loro tesori per il proprio vantaggio finanziario e personale. In parte lo fanno grazie allo sfacciato espediente di persuadere un gran numero di persone a pagare per vedere i beni acquistati dai loro antenati in tempi precedenti e più privilegiati; in parte lo fanno per ottenere dal governo le concessioni tributarie che sono a loro volta condizionate dal permesso di accesso al pubblico; e in parte lo fanno per dimostrare che le loro funzioni “tradizionali” di tutela consentono loro di continuare a risiedere nelle case avite, senza tener conto delle tendenze politiche, sociali ed economiche del tempo.
Sul piano finanziario, politico e sociale questa identità inventata di recente è divenuta la nuova difesa di quello che rimane della vecchia classe terriera. Una volta le collezioni d’arte erano quasi un sottoprodotto occasionale degli interessi di nobili sicuri di sé e in gran parte indifferenti. Ma ora la sopravvivenza stessa dei loro discendenti come occupanti delle dimore avite dipende sempre più dalla posizione privilegiata delle loro collezioni d’arte in quanto parte del patrimonio “nazionale”, e quindi – per estensione – di loro stessi in quanto tutori residenti. L’ingegnosità e l’inventiva che sono state e sono ancora profuse nella formulazione di questo argomento e nella proiezione di questa immagine non sorprenderanno chiunque conosca le capacità di adattamento della classe terriera. Ma alcuni proprietari più onesti di ville di campagna ammettono apertamente che le loro motivazioni sono meno nobili [, e quindi economiche, n.d.r.] […].
In pratica, i proprietari di residenze di campagna hanno per lo più considerato il business delle case signorili come una necessità inevitabile che va sopportata se si vuol conservare quello che rimane di un patrimonio tanto ridotto, piuttosto che la piena maturazione di uno spirito di tutela culturale e di noblesse oblige del quale tutta la storia delle loro casate non sarebbe stata altro che la preparazione e un preliminare. Ma quelli che siano i loro motivi, due sono le principali difficoltà che devono affrontare. In primo luogo, il business delle case signorili è lungi dall’essere piacevole. Come hanno di recente ammesso candidamente due commentatori, “per l’aristocratico inglese medio, l’invasione regolare di turisti non è altro che un male necessario”. E inoltre, non è del tutto chiaro se lo stato continuerà a sostenere all’infinito i proprietari delle ville di campagna nel ruolo di tutori dei loro tesori. […]
Così, nonostante tutti i debiti avvertimenti e tutte le riserve da tenere in considerazione, è chiaro che la profezia di Gladstone è più sbagliata che giusta. La recente un po’ affrettata promozione a tutori del patrimonio “nazionale” degli assillati proprietari di residenze di campagna non fa che conferire ulteriore forza a questa opinione. Come ha giustamente osservato Robert Lacey, “le aristocrazie che hanno successo sono delle eccezioni nell’epoca dell’uomo comune… Pur mettendo in mostra alla fine del ventesimo secolo una notevole capacità di resistenza, l’aristocrazia non può in alcun senso essere definita un’industria in via di espansione”. Al contrario, almeno in Gran Bretagna, è da cent’anni in continuo declino ed è oggi più decaduta e più marginalizzata di quanto non lo sia mai stata. Nell’aprile 1977, il circolo universitario di Cambridge ha approvato una mozione in cui esprime il suo rammarico per la “scomparsa dell’aristocrazia”. Che avessero ragione a rimpiangerne la scomparsa è forse discutibile, ma sul fatto della sua fine possono esservi ben pochi dubbi.
4. Il nobile del Lampedusa
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo
Feltrinelli, Milano 1958
Una delle ultime più importanti rappresentazioni letterarie della figura di un nobile è quella del principe di Lampedusa. Suo è il famoso aforisma pronunciato dal protagonista, il principe di Salina, in riferimento all’eventuale mutamento sociale derivante dall’Unità italiana:
“Noi fummo i Gattopardi, i Leoni: chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra (p. 219)
che, nato per indicare il mutamento sociale, ha poi assunto nel comune sentire un senso più generale dell’immutabilità di situazioni e mentalità cristallizzate anche nella mutevolezza superficiale degli eventi. Tuttavia vi è un altro passo del libro che è molto più interessante e meno noto. Sono le parole che Lampedusa fa dire a Padre Pirrone, il gesuita cappellano di casa Salina, sollecitato da un suo compaesano, don Pietrino lo speziale, a esprimere il pensiero del principe di Salina di fronte all’Unità italiana. Quello che ne emerge è un vivido ritratto della nobiltà, non solo siciliana, ma in generale. L’autore pone in bocca ad un terzo, un ecclesiastico di umili origini, una definizione del “ceto nobile” non malevola, ma neppure agiografica: certamente autobiografica. (TRN)
pag. 230 e segg.
“Vedete, don Pietrino, i ‘signori’ come dite voi, non sono facili a capirsi. Essi vivono in un universo particolare che è stato creato non direttamente da Dio ma da loro stessi durante i secoli di esperienze specialissime, di affanni e di gioie loro; essi posseggono una memoria collettiva quanto mai robusta, e quindi si turbano o si allietano per cose delle quali a voi e a me non importa un bel nulla, ma che per loro sono vitali perchè poste in rapporto con questo loro patrimonio di ricordi, di speranze, di timori di classe.
[…] I ‘signori’ […] vivono di cose già manipolate. […] E con questo non voglio dire che sono cattivi: tutt’altro. Sono differenti; forse ci appaiono tanto strani perché hanno raggiunto una tappa verso la quale tutti coloro che non sono stanchi camminano, quella della noncuranza dei beni terreni mediante l’assuefazione. Forse per questo non badano a certe cose che a noialtri importano molto; chi sta in montagna non si cura delle zanzare delle pianure, e chi vive in Egitto trascura i parapioggia. Il primo però teme le valanghe, il secondo i coccodrilli, cose che invece ci preoccupano poco. Per loro sono subentrati nuovi timori che noi ignoriamo: ho visto don Fabrizio rabbuiarsi, lui uomo serio e saggio, per un colletto di camicia mal stirato; e so di certo che il principe di Làscari dal furore non ha dormito tutta una notte perché ad un pranzo alla Luogotenenza gli avevano dato un posto sbagliato. Ora non vi sembra che il tipo di umanità che si turba soltanto per la biancheria o per il protocollo sia un tipo felice, quindi superiore?”
“Ma se è così, [esclamò don Pietrino], andranno tutti all’inferno!” “E perché? Alcuni saranno perduti, altri salvi, a secondo di come avranno vissuto dentro questo loro mondo condizionato. Ad occhio e croce Salina, per esempio, dovrebbe cavarsela; il giuoco suo lo gioca bene, segue le regole, non bara. Il Signore Iddio punisce chi contravviene volontariamente alle leggi divine che conosce, chi imbocca volontariamente la cattiva strada; ma chi segue la propria via, purché su di essa non commetta sconcezze, è sempre a posto. Se voi, don Pietrino, vendeste cicuta invece di mentuccia, sapendolo, sareste fritto […]
“E fanno molto bene, anche. Se sapeste, per dirne una, a quante famiglie che sarebbero sul lastrico dànno ricetto quei loro palazzi! E non richiedono nulla per questo, neppure un’astensione dai furtarelli. Ciò non viene fatto per ostentazione ma per una sorta di oscuro istinto atavico che li spinge a non poter fare altrimenti. Benché possa non sembrare, sono meno egoisti di tanti altri: lo splendore delle loro case, la pompa delle loro feste contengono in sé un che d’impersonale, un po’ come la magnificenza delle chiese e della liturgia, un che di fatto ad maiorem gentis gloriam, che li redime non poco; per ogni bicchiere di sciampagna che bevono ne offrono cinquanta agli altri; e quando trattano male qualcheduno, come avviene, non è tanto la loro personalità che pecca quanto il loro ceto che si afferma. Fata crescunt.
[… Potreste] dirmi che i signori fanno male ad avere disprezzo per gli altri, e che tutti noi, egualmente soggetti alla doppia servitù dell’amore e della morte, siamo eguali dinanzi al Creatore; ed io non potrei che darvi ragione. Però non è ingiusto incolpare di questo disprezzo soltanto i ‘signori’, dato che questo è un vizio universale. Chi insegna all’Università disprezza il maestrucolo delle scuole parrocchiali, anche se non lo dimostra; […] noi ecclesiastici ci stimiamo superiori ai laici, noi gesuiti superiori al resto del clero, come voi erbari spregiate i cavadenti che a loro volta v’irridono […]
“Questi nobili poi hanno il pudore dei propri guai: ne ho visto uno, sciagurato, che aveva deciso di uccidersi l’indomani, e che sembrava sorridente e brioso come un ragazzo alla vigilia della Prima Comunione; mentre voi, don Pietrino, lo so, se siete costretto a bere uno dei vostri decotti di senna fate echeggiare il paese dei vostri lamenti. L’ira e la beffa sono signorili, l’elegia, la querimonia, no. Anzi voglio darvi una ricetta: se incontrate un ‘signore’ lamentoso e querulo, guardate il suo albero genealogico: vi troverete presto un ramo secco.
[…] Un ceto difficile da sopprimere perché in fondo si rinnova continuamente e perché quando occorre sa morire bene, cioè sa gettare un seme al momento della fine. Guardate la Francia: si son fatti massacrare con eleganza e adesso sono lì come prima, dico come prima, perché non sono i latifondi e i diritti feudali a fare il nobile, ma le differenze. Adesso mi dicono che a Parigi vi sono dei conti polacchi che le insurrezioni e il despotismo hanno costretto all’esilio e alla miseria; fanno i fiaccherai ma guardano i loro clienti borghesi con tale cipiglio che i poveretti salgono in vettura, senza saper perché, con l’aria umile di cani in chiesa. E vi dirò di più, don Pietrino, se, come tante volte è avvenuto, questa classe dovesse scomparire, se ne costituirebbe subito un’altra equivalente, con gli stessi pregi e gli stessi difetti: non sarebbe più basata sul sangue forse, ma che so io… sull’anzianità di presenza in un luogo, o su pretesa miglior conoscenza di qualche testo presunto sacro”.
5. Eléazar ovvero la notte dei tempi - di J. d’Ormesson